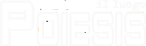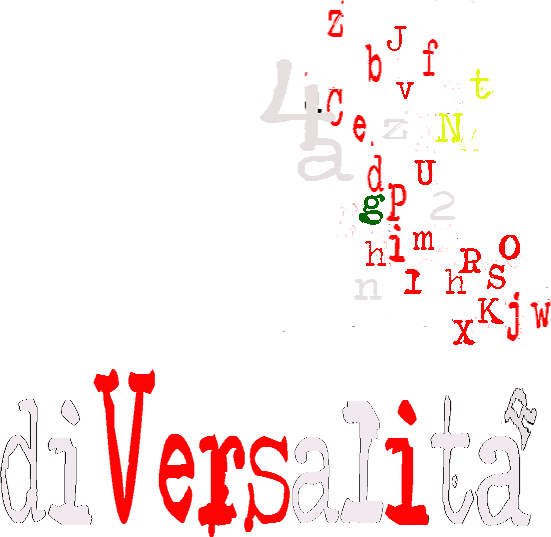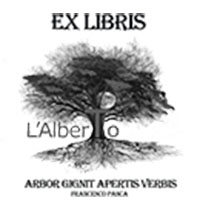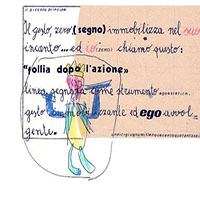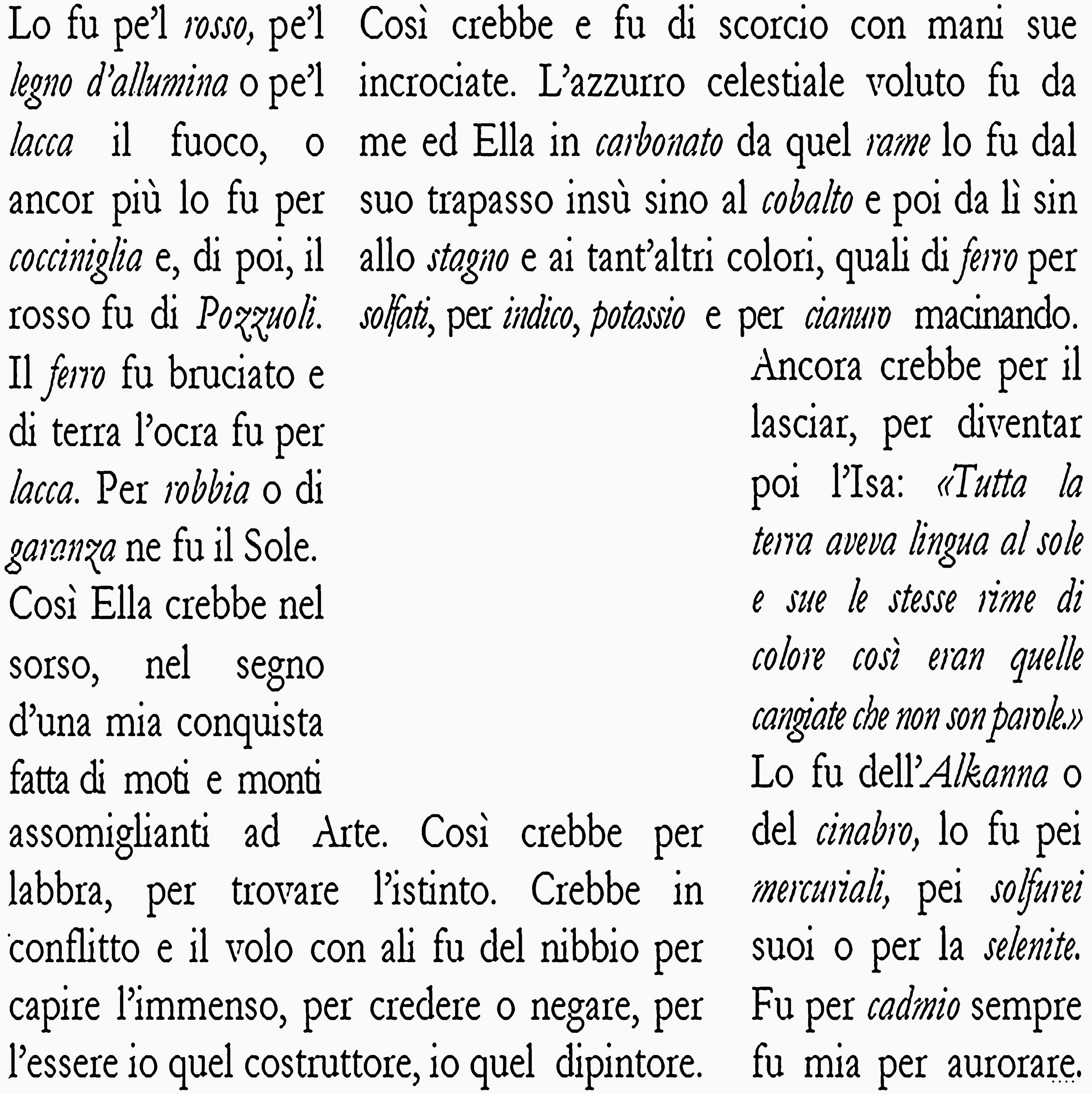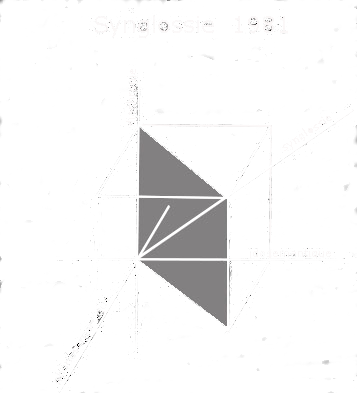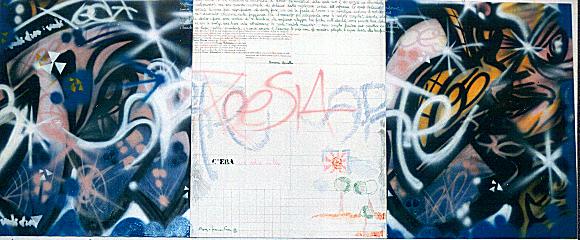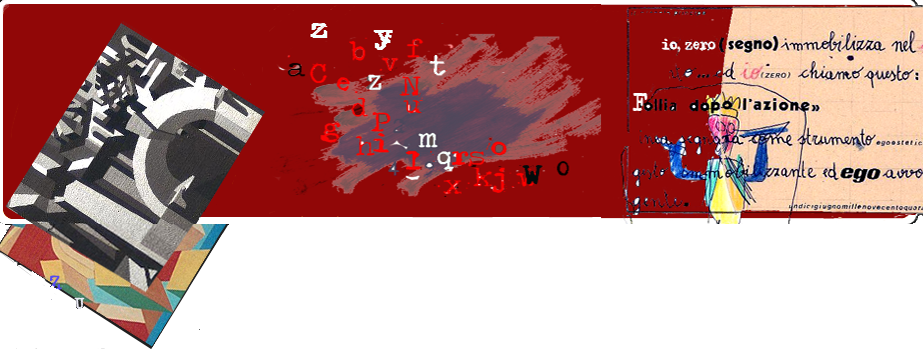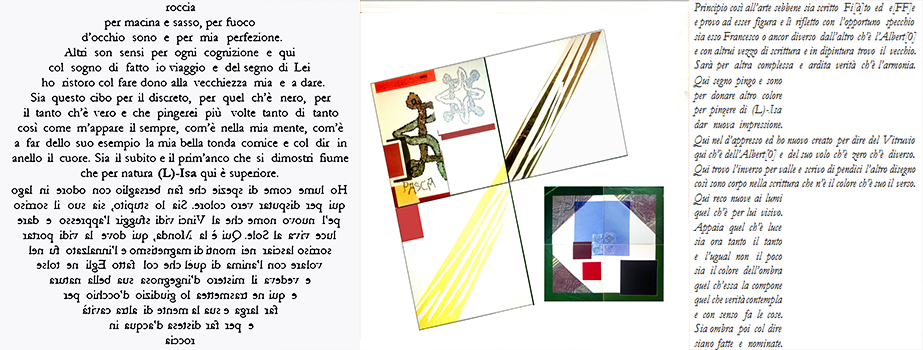Transumare la Storia - continua
Categoria: racconti
Pubblicato: Martedì, 05 Ottobre 2010
Pagina 2 di 2

Micene è da noi lontana ed altrettanto a noi vicina, le mura ciclopiche e i delicati manufatti ritrovati nella città peloponnesiaca ci dice di Agamennone, se mai è esistito. Quei frammenti di storia sono all’unisono, ora qui, per raccontarci una storia ancora incompleta, ma altamente suggestiva come la via dell’ambra che idealmente si percorre. Bari non può essere l’unica tappa per meglio comprendere. La Siritide ci attende così come il Museo Archeologico Nazionale. A Policoro due città greche Siris ed Herakleia coi centri indigeni dell'entroterra completano quell’orizzonte, così come le splendide ceramiche a figure rosse e i raffinati monili in oro filigranato. Ancora una volta la raffinata tecnica utilizzata nei gioielli, monili d’oro lucidissimo, prodotti la cui origine è dalle botteghe locali, sono l’eccezionale di Herakleia. I centri enotri del IX-V secolo a.C. e i centri lucani del IV secolo a.C. fanno la loro parte per sorprenderci. Le armature in bronzo associate ai gioielli in argento, oro e ambra e i vasi indigeni a decorazione geometrica nonché le ceramiche greche figurate e quelle notoriamente etrusche in bucchero fanno la differenza. Comunque sia, il museo rimane luogo, anche se ordinato, didascalico e predisposto alla lettura, sempre meno magico di un sito archeologico. Un manufatto sradicato dal suo contesto abitativo perde l’aura, perde il suono delle sue parole, dei suoi segni. Una comunione forzata di più luoghi crea la non distinzione, ecco allora il bisogno di guadagnare tempo e recarsi lì, nel luogo dove si è accesa e spenta la storia, lì dove le pietre ancora raccontano, lì dove la geografia politica ed economica ha segnato con i suoi granelli l’attraversamento della grande clessidra. Calpestando quei luoghi possiamo restituire momentaneamente con la fantasia quei manufatti alla loro nascita, alla loro vera appartenenza. Vaghiamo dapprima con la mente, pensiamo ad un luogo a noi prossimo e poi trasportiamo il nostro corpo. Ora siamo insieme sulla spianata della Siritide, sulla plateia, dorsale dell’acropoli. Siete in territorio della nuova colonia magnogreca di Heraclea, camminate sulle ceneri di Siris, distrutta nel VI sec. Trovarsi nel centro di una città dove oggi tutto è ricordo, è diventare noi stessi Luogo, è trovarsi, almeno per me, a curiosare nel passato degli altri. Potrebbe … essere un … o il déjà vu, il "già visto o vissuto", la sensazione di un precedente, un’azione verificata probabile. In questo momento siete insieme all’archeologo Rino Bianco direttore del museo della Siritide, all’editore Lorenzo Capone, allo storico Maurizio Nocera e a chi qui scrive. L’archeologo ci mostra i vari aspetti della vita della città dal 432 a.C., data di fondazione, alla sua romanizzazione nel III sec. a.C. È bella la Storia così descritta, in questo momento non si è soli, la città improvvisamente si rianima, prende forma, le fondamenta non sono più vago contorno ma volumi abitati non dissimili dai nostri, almeno nelle aspettative. Tutto è l’uguale di sempre. Tutto continua a scorrere. Scorre la vita degli abitanti così come le acque canalizzate e portate sino al margine più estremo della plateia. È li che le acque vengono raccolte e restituite ai fiumi, all’Agri ed al Sinni che scorrono nell’omonima valle. Non vi è più il silenzio. Gli oggetti precedentemente visionati nel luogo dei luoghi sono lì tutti al loro posto. Si può persino visitare l’abitazione. Siamo ospiti nei locali, accomodati da premurosi Eracleioti, Siritidi disposti ad accogliere lo straniero. In alcune abitazioni fanno bella mostra statuette e pinakes votive tratte da modelli lisippici e prassitelici. L’operosità dei locali non è solo vita, è pensiero rivolto anche alla morte ed allora eccoli lì intenti con Crateri, hydriai e pelikai pronti ad usarli per i riti di incinerazione ed inumazione. Altrettanto solerti siamo qui ad ascoltare che rivolgimenti sociali, specie quelli avvenuti nel I sec. a.C. hanno portato ad importanti ritrovamenti di tesoretti di gioielli e monete. L’uomo da sempre nasconde e protegge i propri averi, così come da sempre divide il sacro dal profano, la vita dalla morte. Il tempio ha il suo recinto sacro, La necropoli è nettamente distinguibile dall’acropoli. Testimonianza è la necropoli di Armento, della fine del VI sec. Collettivo e privato mai indebitamente mescolato. Le feste sono l’opportunità per ulteriormente diversificare. Il termine territorio è parola magica. La stessa fonia è evocativa e ci suggerisce oltre alla parola terra anche il poter essere sconfinato con quel rincorrersi e rotolarsi nei dentali che ne deducono un percorso vivo, dinamico. Ora quel territorio diventa lungo percorso e diventa Sibaritide. Siamo nella civiltà degli Enotri.
É l’Età del Ferro. Sorte strana è toccata a questa terra, ma inevitabile perché spazzata dalle colonizzazioni, dai coloni greci giunti dall'Acaia nel 730-720 a.C. circa. Qui fondarono Sibari, Sybaris dopo la vittoria contro Siris alleata a Crotone e Metaponto e culminata con la battaglia del Traente 510 a.C. Ci fu persino la deviazione del fiume Crati. La città è definitivamente sconfitta ed allagata. Le vicende storiche ci portano alla riedificazione. Il nuovo impianto della città lo scopriamo progettato dal famoso architetto e urbanista Ippodamo di Mileto con strade che si intersecano ortogonalmente. L’impianto è razionale. Composto dal classico cardo e decumano. Ma i conflitti tra sibariti e ateniesi ci raccontano che portarono a un conflitto interno. Ancora una volta quel territorio s’andò a modificare. Roma è lì ad attendere. Nuovi coloni prendono il sopravvento nel 194 a.C. La colonia romana diventa Copiae, poi Thurii. Testimonianze medioevali ci conducono in quel territorio sostando per oltre mille anni. Il nostro Luogo è ricco di storia ed adesso è Grumentum, con il suo impianto urbanistico del III secolo a.C., ad apparirci nella sua forma allungata. L’orografia collinare si disegna su tre vie principali parallele, intersecate ad angolo retto da vie secondarie. Sei porte ci assicurano la presenza della città. Tre km di perimetro occupano un’area di circa 25 ettari. Poco più di un decimo, ci dicono, è riportato alla luce. Il teatro è di epoca augustea. Poi due piccoli templi di epoca imperiale, una ricca domus, denominata "Casa dei mosaici" del IV secolo. Un bellissimo foro è racchiuso da portici da cui ci affacciamo per visionare i resti di due templi sui lati sud e nord, il capitolium. Nei pressi del foro, sul lato ovest troviamo i resti di un edificio termale. Chiude l’anfiteatro costruito sulle pendici della collina nel I secolo a.C. e modificato in epoca imperiale. Il nodo di questa città è importante. Da Grumentum passava la via Herculea che la collegava con Venusia (291 a.C.) ed ancora un'altra strada conduceva alla via Popilia sul versante tirrenico. Deduciamo l’importanza strategica, due mari collegati via terra. Tito Livio, Annone, Annibale, Tiberio Sempronio Longo, Gaio Claudio Nerone, le guerre puniche e quant’altro la storia ci ricorda passa tutto da Grumentum. I Grumentini ci ricordano di aver occupato la Val d'Agri fondando nuovi centri fortificati che sono gli attuali paesi di Saponara, ribattezzata poi Grumento Nova proprio in onore di Grumentum. Nel 312 d.C. il 17 novembre sotto il prefetto Agrippa abbiamo il primo martire cristiano, S.Laverio. Quest’ultimo venne decapitato fuori le mura di Grumentum alla confluenza dei fiumi Agri e Sciaura. Persino i saraceni si affacciano nel IX e X secolo. La via della transumanza s’appresta a terminare. Termina proprio dove un’altra transumanza si è consumata ciclicamente nel tempo. La direttrice è quella del tratturo Pescasseroli-Candela, verso la piana di Bojano, l'antica Bovianum, capitale dei Sanniti Pentri e fondata intorno al IV secolo a.C. Qui la storia è intrigante, il dubbio è tra il percorrere il tratturo Pescasseroli-Candela e sentirsi spinti dalle mandrie della transumanza, passando all'interno della città sull’asse che prende il nome di "decumano " lì dove si aprono Porta Bojano, verso Ovest, e Porta Benevento verso Est, oppure prendere il tratturello del Matese, denominato "cardo", dove si corre per Porta Terravecchia e Porta Tammaro. Decidiamo. Ecco immediatamente visibili i resti di Porta Terravecchia. Vistose scanalature sugli stipiti del vano porta indicano un ingresso a saracinesca, a ghigliottina. È intuibile uno scorrere dall’alto in basso e viceversa. Sono i non battenti di quella porta. Sulla destra ecco i resti della torre circolare con un opus reticulatum che ne aggrazia decorativamente i lineamenti. Più avanti, oltrepassata la porta, s’affaccia il "cardo" che conduce ad alcune costruzioni contadine di epoca medievale. È evidente il riutilizzo del materiale di risulta. All'incrocio del cardo con il decumano, impossibile non soffermarsi sullo slargo di destra dove s’apre il Foro. A sinistra è un bel colonnato ionico non scanalato. Fa bella mostra di sé la Basilica. Sepino incanta. Sepino è calda ed è viva come una città vera. La vita s’avverte a pelle, l’acqua sebbene assente la vedi sgorgare da una bellissima fontana sul decumano il cui fregio è originalissimo. Gli impluvi in pietra provvedono alla raccolta delle acque piovane in cisterne sotterranee. La pietra qui canta, ti accoglie ed ti invita a sostare. Sulla sinistra ci si immette in una casa signorile, il cui atrio, con un grande impluvio, s’addentra in alcuni ambienti. L' impluvio è in pietra ed è qui che ci dicono che è stata ritrovata una testimonianza sannita in terracotta (II sec. a.C.). L’impluvio ci parla la sua storia e ci dice di lettere osche scalfite. Avvicinarsi alla fontana in prossimità delle terme è vedere i Sepini negli impluvi impegnati a discorrere di amenità e bellezze.
Il fregio granitico di quella fontana, per me è un invito a meditare. Da un superbo grifone alato schizza una fontanella d’acqua gentile che addolcisce i suoi lineamenti grifagni. Sono inebriato e vado ad abbracciare poco più in là un tronco di colonna ionica scanalata con i suoi pianetti. L’abbraccio, conto quelle scanalature; sono venticinque. Sogno ancora su quel numero. Sepino è una città che dà sicurezza, ci sentiamo circondati da mura fortificate. Il perimetro è breve ed al contempo maestoso. Milletrecento metri e ventinove torri circolari, merlate, alte oltre sette metri sono collegate tra di loro da un camminamento di guardia. Lo spessore è circa di due metri ed ha forma squadrata. Le porte anch’esse fortificate. Porta di Bojano è l'ingresso principale alla città ed è l'unico arco affiancato da due torri circolari. Sul piedritto accanto alla chiave di volta l'effigie di Ercole, più in alto l’iscrizione rettangolare che si ripete su tutte le quattro porte. Qui Tiberio e Druso sono ricordati come i finanziatori per la costruzione delle mura di cinta e delle porte. Come ogni città anche Sepino ha il suo teatro; un semi cerchio con diametro massimo di circa 62 metri e con una capacità di circa 3.000 posti a sedere su ventotto file di gradoni divisi in tre settori: ima, media e summa cavea. Anche questa sosta incanta, anche qui è scegliere il proprio punto di vista: Stare in basso? Nel mezzo o in alto? Ciascuno prenda la collocazione che l’aggrada. Noi proseguiamo lungo le mura e si ritorna al parcheggio di Porta Terravecchia. Il breve diario di una transumanza è stato il Caso che non è Causa, ma da Causa, a pensarci bene, tutto può nascere, tutto può essere dettato. Al Caso ci si può essere condotti, inaspettatamente, anche attraverso l’improvvisa necessità di una Causa, condotti persino dalla stessa Causa. Perché essere costretti a chiedere o a dare “due fiorini”. Scrivere chissà cosa potrà mai portare.
- << Indietro
- Avanti